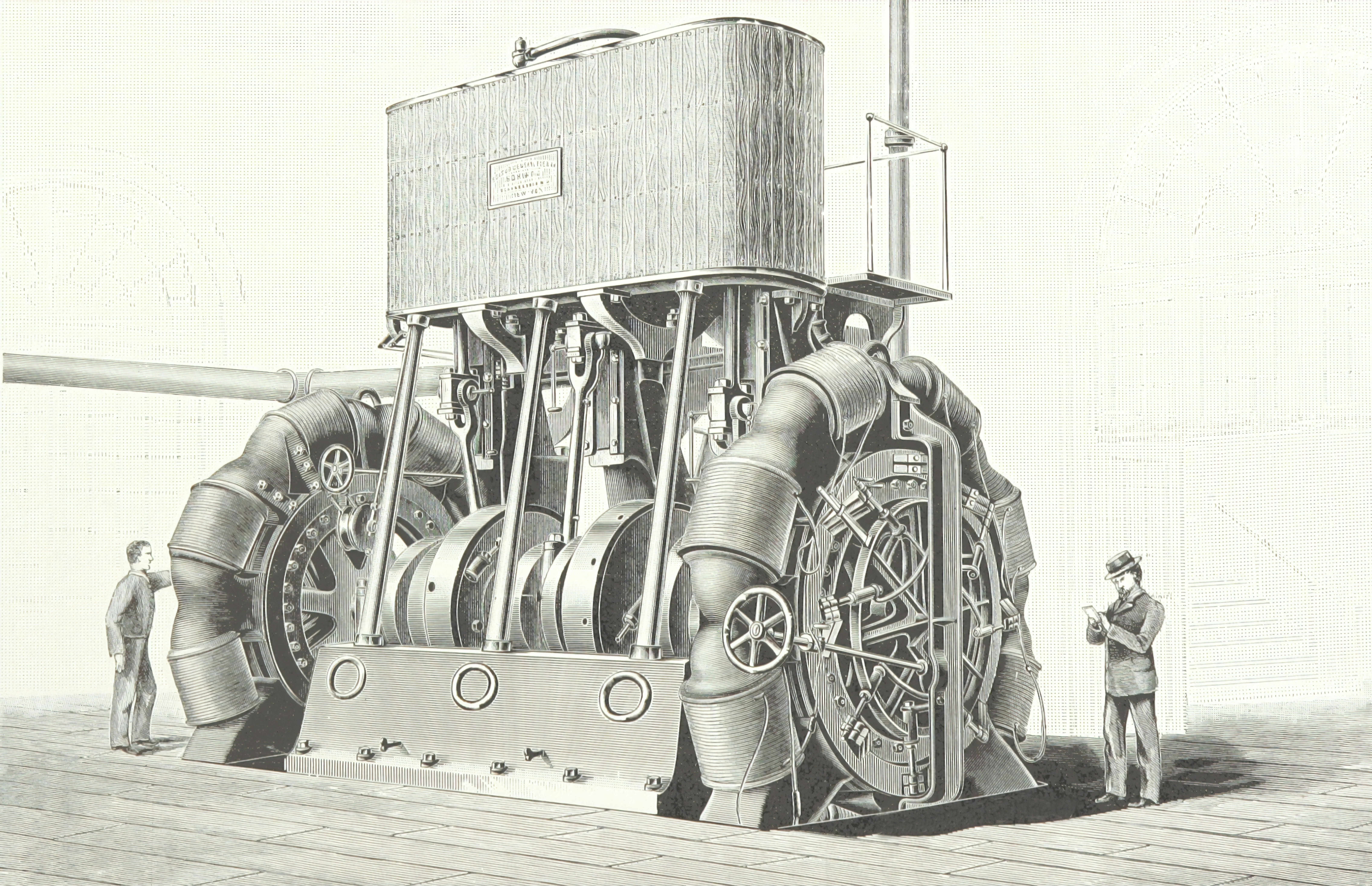Una delle paure più diffuse – e forse non discusse abbastanza – riguarda la paura che molti hanno di perdere il lavoro come conseguenza del diffondersi dell’Intelligenza Artificiale. Si tratta di un timore lecito e non infondato: coloro che liquidano come paure infondate queste preoccupazioni stanno ignorando la storia, in modo più o meno consapevole. L’argomento va affrontato in modo ampio ed esaustivo e di certo non è questa la modalità più adatta per sviscerare a fondo questo tema, ma qualche considerazione possiamo farla: tutto subisce delle evoluzioni, mondo del lavoro compreso, ma in alcuni momenti della storia i cambiamenti sono talmente radicali da deviare per sempre il corso delle cose. Possiamo individuare tre momenti esemplari in cui una scoperta o una serie di soluzioni adottate hanno avuto implicazioni irreversibili sul nostro modo di operare: una è certamente la nascita dell’Intelligenza artificiale, l’altra è la serie di soluzioni adottate durante la cosiddetta Rivoluzione Industriale, ed infine l’invenzione della stampa a caratteri mobili da parte di Gutenberg. Questi tre momenti hanno molte cose in comune. Le implicazioni di alcune soluzioni non sono immediate, anche se oggi siamo più consapevoli rispetto al passato, ma ancora non ci rendiamo davvero conto di cosa ci aspetta, e non potrebbe essere altrimenti, poiché dobbiamo ancora studiare e approfondire ciò che abbiamo appena iniziato a sviluppare.
In Europa il sistema della stampa venne introdotto dal tedesco Johannes Gutenberg a metà del 15° secolo. Si basava appunto su caratteri mobili realizzati in metallo, disposti a mano su di un piano, in modo da creare una versione della pagina e imprimerla su tutte le copie necessarie. Una volta conclusa la stampa, il piano veniva liberato e si componeva la pagina successiva. Prima di allora, quando le copie dei libri si scrivevano solo a mano, la cultura era ovviamente ben più costosa. L’invenzione di Gutenberg ebbe l’effetto di aumentare la capacità di replica delle copie, renderle uniformi e soprattutto abbattere i costi di produzione, aprendo di fatto la strada alla cultura di massa e alla libertà della conoscenza. Ma come per altre scoperte, quella non fu propriamente una sua invenzione, era stata sviluppata e introdotta precedentemente in Cina, dove sappiamo che era usata fin dal 6° secolo a.C. I copisti, ossia coloro che copiavano a mano i libri, ovviamente scomparvero, copiare un testo come la Bibbia richiedeva fino ad un anno di lavoro, si trattava certamente di un oggetto pregiato, ma ben più costoso e con possibilità di errori.
Andiamo ora un po’ più avanti nel tempo: alla Rivoluzione Industriale, che ebbe inizio convenzionalmente alla nascita di una serie di invenzioni rivoluzionarie realizzate tra il 1760 e il 1780, rinnovando la tecnologia delle industrie. Nel 1764 il tessitore J. Hargreaves (1720-1779) costruì una filatrice multipla in grado di permettere a un solo operaio di azionare 8 fusi per volta; nel 1768 R. Arkwright (1732-1792) mise a punto un telaio meccanico idraulico. La scoperta più importante però fu ad opera di J. Watt, che tra il 1765 e il 1781 inventò la macchina a vapore la quale ebbe l’effetto di aumentare la disponibilità di energia, portando in primis a un imponente incremento dell’estrazione di carbone, e il suo impiego nell’industria, nell’agricoltura, nei trasporti rese possibile la produzione e lo scambio di beni su una scala impensabile fino a quel momento. Non mancarono ovviamente gli oppositori: il movimento operaio in Gran Bretagna, nel 19° secolo, reagì violentemente all’introduzione delle macchine nell’industria, le quali erano ritenute causa di disoccupazione e di bassi salari. In particolare il movimento “luddista” prende nome dall’operaio Ned Ludd, che nel 1779 infranse un telaio. Oggi nessuno pretenderebbe di estrarre il carbone a mano e di passare il suo tempo su di un telaio a bassa capacità produttiva, ma occorre pensare che allora i cambiamenti erano visti in modo così radicale da sembrare una minaccia.
Da questi presupposti bisogna partire per comprendere l’impatto di alcune invenzioni. Molto probabilmente anche nel caso dell’Intelligenza Artificiale siamo di fronte a qualcosa che rivoluzionerà il nostro modo di lavorare, ma non si tratta necessariamente di una sostituzione delle professioni, quanto di un profondo rinnovamento delle modalità con le quali vengono svolte. Riqualificarsi sarà un passaggio obbligato, per essere in grado di fare le cose diversamente, ma alcuni mestieri altamente routinari è bene che siano forse supportati dalle macchine. La capacità di elaborare una mole di dati sempre più elevata ci mette ad esempio nelle condizioni di fare scelte più consapevoli, di ridurre l’errore umano, di effettuare scoperte e previsioni in modo più veloce e preciso. Si pensi ad esempio alla medicina: in molti ambiti si sta sperimentando l’impego dell’AI, come ad esempio nei sistemi di predizione, in grado di identificare possibili patologie ancora prima che queste si manifestino.
In conclusione, occorre non focalizzarsi sugli effetti di rottura generati da nuove invenzioni nell’immediato ma ragionare sempre in prospettiva. La domanda sul fatto che l’Intelligenza Artificiale “ruberà” o meno il nostro lavoro è un falso quesito: dovremmo piuttosto chiederci quali influenze avrà sul nostro modo di lavorare e quali vantaggi e pericoli concreti porta con sé. Se da un lato dovremo tutti rivedere alcuni aspetti pratici del nostro lavoro, forse non è necessariamente un male, dovremo però essere in grado di muoverci di pari passo con l’evoluzione di questi processi, e non attendere anni prima di adeguarci a qualcosa che difficilmente potremo cambiare. Sarà più facile progredire con i nuovi sistemi che cercare di fermali. Certo queste invenzioni oggi hanno un maggiore impatto sui lavori intellettuali, per una maggiore terziarizzazione diffusa nelle economie avanzate, a differenza del passato, quando le macchine hanno agito per sostituire la forza umana, ma nulla è destinato a restare immutato, almeno fino a quando l’essere umano sarà animato da curiosità.